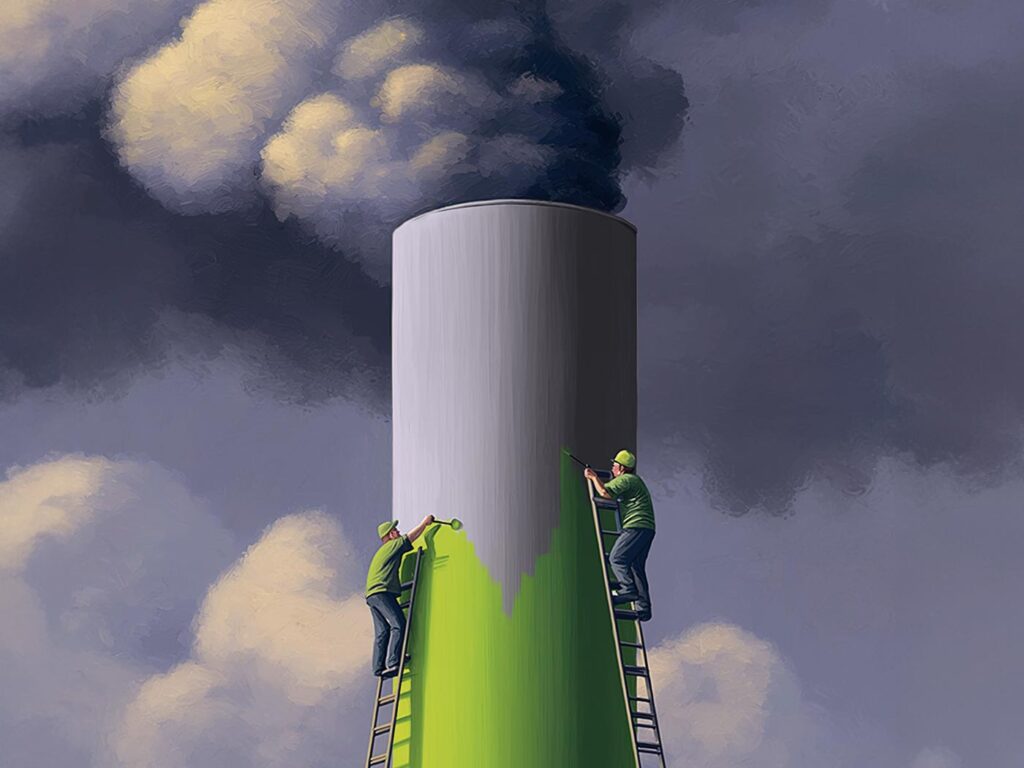

Responsabile dell’Osservatorio nazionale Ambiente e legalità di Legambiente
Condividi
Un reato contro l’ambiente ogni 18 minuti, dal 1992 al 2023. Può bastare un ‘fotogramma’ per comprendere quanto sia grave, diffusa e persistente la criminalità ambientale nel nostro Paese. Quel dato riassume i risultati del lavoro di ricerca che Legambiente ha avviato nel 1994 attraverso il suo Osservatorio nazionale Ambiente e Legalità, pubblicando, con l’Arma dei carabinieri e l’istituto di ricerca Eurispes, il primo rapporto sull’ecomafia. Da allora, l’attività costante di monitoraggio, realizzata grazie alla collaborazione con tutte le forze dell’ordine e le Capitanerie di porto, ha consentito di mappare 902.356 reati ambientali, alla media di 79,7 reati al giorno, 3,3 ogni ora, uno ogni 18 minuti, appunto. Le persone denunciate sono state 727.771 e 224.485 i sequestri. La Campania, sulla base dei dati suddivisibili a livello regionale dal 1997 al 2023, è al primo posto della classifica con 117.919 reati, seguita dalla Calabria (84.472), dalla Sicilia (82.290 illeciti penali) e dalla Puglia (73.773 reati). Le quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa rappresentano da sole il 45,7% del totale nazionale. E non si tratta di una coincidenza.
Quando coniammo il termine ‘ecomafia’, entrato nel 1999 nel vocabolario Zanichelli, volevamo denunciare il ruolo diretto delle organizzazioni mafiose, tutte, da Cosa nostra alla ‘ndrangheta, dalla camorra alla Sacra corona unita, nello sfruttamento selvaggio del nostro straordinario patrimonio ambientale. Da allora sono state centinaia le inchieste, dai traffici illegali di rifiuti a quelli di specie protette, dall’industria del mattone illegale fino all’infiltrazione nel mercato delle energie rinnovabili, che hanno confermato la fondatezza di quell’analisi, con 378 diversi clan coinvolti.
Non tutti i reati ambientali sono, ovviamente, riconducibili alle mafie ma sono quasi sempre crimini connessi ad attività economiche, realizzate con l’obiettivo di accumulare profitti illeciti, nell’assoluto disprezzo delle regole, delle risorse naturali e della salute delle persone, che hanno generato un fatturato illegale, dal 1995 al 2023, stimato da Legambiente in 259,8 miliardi di euro. Basta pensare alla gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi, che vedono come protagoniste imprese, consulenti, professionisti capaci, con le loro relazioni e competenze, di costruire vere e proprie filiere di smaltimento illegale, dentro e fuori i confini nazionali.
Anche in questo caso i numeri aiutano a comprendere le dimensioni raggiunte da queste organizzazioni di eco-criminali. Dal 2002 a dicembre 2024, sulla base del delitto di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti (introdotto nel 2001 come art. 53 bis del cosiddetto Decreto Ronchi e oggi art. 452 quaterdecies del Codice penale) sono state condotte 627 inchieste, con 3.622 ordinanze di custodia cautelare, 10.936 persone denunciate e ben 1.732 aziende coinvolte. Il 37,8% di queste indagini hanno riguardato, di nuovo, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Impressionante il dato sui rifiuti sequestrati, relativo peraltro a poco più della metà delle indagini svolte in tutta Italia: 61 milioni di tonnellate, in larga prevalenza fanghi di depurazione e scarti industriali.
Gli illeciti ambientali sono, insomma, dei veri e propri “reati spia”, che segnalano gravi anomalie nelle diverse filiere in cui vengono analizzati ogni anno nel Rapporto Ecomafia: ciclo dei rifiuti (dalle discariche ai traffici illeciti), ciclo del cemento (dalle cave all’abusivismo edilizio), animali (dal bracconaggio ai traffici di specie protette), incendi boschivi e di vegetazione, patrimonio culturale. Vale per le quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso ma anche per quelle che occupano, da tempo, posizioni di rilievo della classifica nazionale. In quella relativa sempre al periodo 1992-2023, il Lazio è al quinto posto, seguito dalla Toscana e dalla Sardegna. La Lombardia, con 37.794 reati ambientali, è la prima regione del Nord.
Accanto ai valori assoluti, a preoccupare è il trend, purtroppo in crescita, della criminalità ambientale. Nel 2023, ultimo dato disponibile, gli illeciti penali sono stati 35.487, registrando +15,6% rispetto al 2022, con una media di 97,2 reati al giorno, 4 ogni ora. I fenomeni più gravi si concentrano, come sempre, nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa (Campania, Puglia, Sicilia e Calabria) con il 43,5% dei reati accertati su scala nazionale, +3,8% rispetto al 2022.
A crescere, grazie al lavoro quotidiano di forze dell’ordine e magistratura, è anche il numero delle persone denunciate (34.481, +30,6%), così come quello degli arresti (319, +43% rispetto al 2022) e quello dei sequestri (7.152, +19%). L’analisi delle diverse tipologie di illeciti conferma la pressione del ciclo illegale del cemento (13.008 reati, +6,5%), sempre al primo posto tra i reati ambientali, ma è da segnalare l’impennata degli illeciti penali nel ciclo dei rifiuti: 9.309, + 66,1%, a fronte di un aumento dei controlli di oltre il 60%. Al terzo posto con 6.581 reati si colloca la filiera degli illeciti contro gli animali, seguita dagli incendi dolosi, colposi e generici, con 3.691 reati. Crescono anche i numeri dell’aggressione al patrimonio culturale (642 i furti alle opere d’arte, +58,9% rispetto al 2022) e degli illeciti nelle filiere agroalimentari (45.067 illeciti amministrativi, + 9,1% rispetto al 2022), a cominciare dal caporalato.
Fin qui la ‘geografia’ della criminalità ambientale in Italia. Ma questo lavoro, reso possibile grazie alla collaborazione, come già accennato, con tutte le forze dell’ordine, le Capitanerie di porto, l’Agenzia delle dogane, l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) è sempre stato finalizzato, accanto a una maggiore conoscenza di questi fenomeni, all’elaborazione di proposte concrete, da sottoporre al governo e al Parlamento. È con questo spirito che Legambiente si è fatta da subito promotrice dell’inserimento dei delitti contro l’ambiente nel Codice penale. Ci sono voluti 21 anni per vedere, finalmente, approvata la legge 68 che nel 2015 ha introdotto il Titolo VI Bis, intitolato Dei delitti contro l’ambiente. La nostra associazione ricorda bene il pomeriggio del 19 maggio 2015 quando l’aula del Senato, guidata dall’allora presidente Pietro Grasso, approvò a larghissima maggioranza quella legge (170 voti favorevoli, 20 contrari e 21 astenuti). Una normativa che, numeri alla mano, sta dimostrando la sua efficacia, con oltre 5.700 reati contestati da giugno 2015 a dicembre 2023 (compresi quelli previsti dalla modifica del Testo Unico Ambientale del 2006, per gli aspetti sanzionatori) e che, soprattutto, ha fatto da spartiacque tra le sostanziale impunità determinata dai tempi esigui di prescrizione previsti per i reati di natura contravvenzionale e le pene, finalmente adeguate, per i delitti commessi contro l’ambiente.
Quella legge, frutto di un’intesa bipartisan tra la maggioranza di allora (in particolare Pd e Sel) e parte dell’opposizione (Movimento Cinque stelle) ha collocato l’Italia all’avanguardia in Europa per quanto riguarda l’effettivo riconoscimento della tutela penale dell’ambiente. La direttiva comunitaria del 2008, infatti, si è rivelata largamente insufficiente, tanto da spingere la stessa Commissione europea a elaborare una nuova proposta di direttiva, approvata in via definitiva nell’aprile del 2024, in cui sono elencate ben 20 fattispecie di delitti ambientali, diverse delle quali facilmente
riconducibili ad alcuni dei delitti, come l’inquinamento o il disastro ambientale, già previsti dal nostro Codice penale e altri, come il traffico illegale di rifiuti, ispirati proprio dall’esperienza maturata in Italia.
Tutto bene, allora? Molto, in realtà, resta ancora da fare, come Legambiente non si stanca di ripetere ogni anno, durante la presentazione del Rapporto Ecomafia. Sono sei, in particolare, i ‘pilastri’ di una nuova stagione di riforme con cui rafforzare la prevenzione e il contrasto della criminalità ambientale nel nostro Paese:
a. recepire quanto prima la nuova direttiva europea in materia di tutela penale dell’ambiente, che introduce nuove fattispecie di reato rispetto a quelle già previste dal nostro Codice penale e prevede l’adozione di una strategia nazionale contro la criminalità ambientale;
b. introdurre nel Codice penale i delitti contro le agromafie;
c. introdurre nel codice penale i delitti contro gli animali, compresi quelli contro la fauna e le specie protette, come prevede la stessa direttiva comunitaria;
d. restituire alle Prefetture i pieni poteri per la demolizione degli immobili che i Comuni non hanno abbattuto, applicando, com’era nelle intenzioni del legislatore, l’art. 10 bis della legge 120/2020 anche alle ordinanze di demolizione emesse prima dell’approvazione delle norma;
e. inasprire le sanzioni contro i reati nel ciclo dei rifiuti, trasformando in delitti i reati contravvenzionali previsti dagli art. 256 (attività di gestione non autorizzata) e 259 (traffico illecito internazionale di rifiuti), attualmente previsti dal Testo unico ambientale e innalzando fino a 8 anni la pena prevista dall’art. 452 quaterdecies del Codice penale;
f. completare l’approvazione dei decreti attuativi del Sistema nazionale di protezione ambientale e potenziare gli organici delle Agenzie regionali, per garantire controlli adeguati sul Pnrr e sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.
La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è entrata tra i principi fondamentali della nostra Repubblica, grazie alla modifica, approvata quasi all’unanimità, nel 2022 dell’art. 9 della Costituzione. Oggi ha bisogno di una nuova stagione di sensibilità e attenzione condivisa da parte di tutte le forze politiche, a cui è richiesta, per l’impegno assunto con quel voto “anche nell’interesse delle future generazioni”, coerenza e corresponsabilità.
Questo contributo è tratto dal volume tematico
Giustizia, sostenibilità e transizione verde
Ferruccio De Bortoli