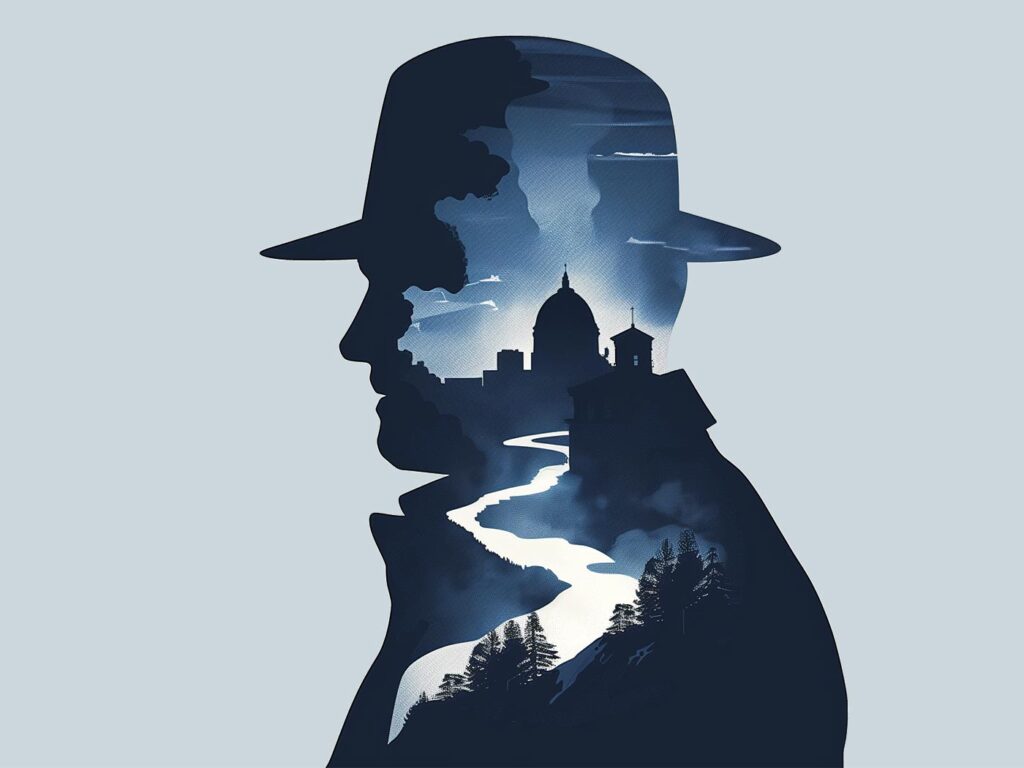

Presidente Autorità nazionale Anti Corruzione
Condividi
La trasparenza rappresenta un requisito essenziale per ogni pubblica amministrazione, non solo in quanto efficace presidio anticorruzione, ma anche come strumento di partecipazione democratica e forma di esercizio della sovranità popolare, fondata sull’articolo 1 della Costituzione.
Essa, infatti, configurandosi come accessibilità alle procedure, alle scelte e alle decisioni che le amministrazioni pongono in essere nell’ambito della propria attività, consente al cittadino forme diffuse di controllo sull’operato delle istituzioni, sull’utilizzo delle risorse pubbliche e, quindi, in ultima analisi, sul rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, ponendosi come presupposto fondamentale per la realizzazione delle politiche di governo aperto, volte alla promozione della partecipazione dei portatori di interessi ai processi decisionali pubblici, a sostegno della democrazia e della crescita inclusiva.
La trasparenza viene dunque a configurarsi come un principio generale dell’azione amministrativa, attinente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti sociali e civili che devono essere garantiti ai cittadini.
Sono vari gli istituti attraverso i quali si può realizzare la trasparenza amministrativa: dal più maturo e risalente diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a chi abbia un interesse qualificato a partecipare ad una determinata procedura, fino al più recente accesso civico generalizzato, esercitabile da chiunque, anche indipendentemente da uno specifico interesse, passando per l’accesso ai dati personali, utile, oltre che tutela i propri diritti fondamentali, anche per verificare quanto l’amministrazione sta concretamente facendo sul nostro conto.
Nel contesto attuale, segnato dalla rapida digitalizzazione dei processi amministrativi e dal sempre più ampio ricorso a strumenti tecnologici da parte delle stesse amministrazioni, acquista un rilievo crescente la trasparenza che si attua attraverso la raccolta e la pubblicazione di alcune delle informazioni e dei documenti più significativi per comprendere come è organizzata e come sta operando una determinata amministrazione pubblica.
La raccolta e pubblicazione digitale dei dati risponde a precise finalità di interesse pubblico nella misura in cui soddisfa l’esigenza di tracciare l’attività amministrativa e di assicurare la piena attuazione del diritto del cittadino alla trasparenza.
Il digitale, infatti, oltre ad agire come veicolo di semplificazione dei processi, assolve anche ad una fondamentale funzione di trasparenza, permettendo ad un vasto pubblico di accedere al patrimonio informativo della PA, favorendo l’interoperabilità tra le stesse amministrazioni, agevolando la comunicazione tra queste e gli utenti e consentendo il coinvolgimento di questi ultimi nelle scelte strategiche assunte dai decisori pubblici.
La trasparenza amministrativa, infine, è funzionale a ridurre il rischio di infiltrazioni criminali, con particolare riferimento alla criminalità organizzata. I recenti mutamenti del tessuto socio-economico del nostro Paese e la globalizzazione hanno comportato una sostanziale trasformazione del fenomeno mafioso, dando luogo, nei contesti del potere e dell’alta finanza, ad una pericolosa commistione tra economia legale ed economia criminale, grazie alla quale diviene possibile reinvestire l’enorme mole di capitali prodotti con attività illecite.
L’influenza dell’economia criminale sul mercato legale diventa pervasiva proprio a causa della fitta rete di relazioni che la criminalità organizzata riesce a tessere, in modo spesso insospettabile, in tutti i settori e a tutti i livelli della società e in conseguenza della sua capacità di infiltrarsi, con le sue tentacolari ramificazioni, nel mondo degli appalti pubblici, della finanza, della politica. Alla luce di ciò, nell’ottica della prevenzione (oltre che della repressione) del crimine e della promozione dell’integrità, il potenziamento degli strumenti della trasparenza deve costituire uno degli obiettivi prioritari delle istituzioni pubbliche, perché è attraverso la pubblicazione dei dati e il tracciamento dei processi che si eliminano le zone d’ombra e diviene conseguentemente anche possibile fare emergere le connivenze, i conflitti di interessi e quei casi di maladministration che sovente nascondono rilevanti profili penalistici.
Particolarmente rilevante appare il valore della trasparenza, nello specifico, per gli enti che gestiscono i beni confiscati alle mafie, il cui significato va anche al di là di quello legato alle forme di trasparenza ordinariamente dirette ad assicurare la conoscibilità dell’agire pubblico.
Come è noto, gli enti assegnatari di tali beni sono tenuti a formare un apposito elenco dei beni confiscati affidati alla loro temporanea gestione, per renderlo accessibile alla collettività con adeguate forme di pubblicità sul proprio sito web istituzionale. Il predetto elenco deve contenere i dati relativi alla consistenza, alla destinazione e all’utilizzo dei beni, nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale.
La ratio della norma è, evidentemente, quella di assicurare alla comunità pieno accesso alle informazioni concernenti i beni confiscati al crimine e il loro utilizzo, come precondizione affinché i cittadini possano riappropriarsi della ricchezza che la malavita ha loro sottratto.
La destinazione sociale dei patrimoni accumulati con il malaffare non risponde soltanto ad un obbligo giuridico, stabilito dall’articolo 48 del Codice antimafia, ma esprime anche un alto significato simbolico, di riscatto delle istituzioni e dei territori, di riparazione dei danni collettivi causati dalle organizzazioni malavitose. Rendere disponibili per fini istituzionali i patrimoni confiscati alla criminalità organizzata rappresenta un valore che va ben oltre il vantaggio materiale di poter fruire di nuovi edifici pubblici, nuove caserme o nuove scuole; significa, soprattutto, consentire l’affrancamento e la liberazione del territorio dall’ipoteca mafiosa, a beneficio della popolazione intera.
La prima garanzia della piena riappropriazione, da parte della collettività ferita, di ciò che le è stato strappato con le attività criminali è proprio la trasparenza sui beni confiscati e sulle relative procedure, senza la quale l’esercizio dei diritti è precluso. Per tali motivi, se in generale un’amministrazione non trasparente appare inidonea a svolgere la propria funzione e il proprio ruolo, a maggior ragione peserebbe un eventuale difetto di trasparenza da parte di enti che gestiscano beni confiscati. La trasparenza sui patrimoni accumulati con il malaffare, anche se assicurata da enti diversi da quelli nei quali le mafie si erano infiltrate, consente di liberare dall’ombra della mafia ingenti ricchezze che possono contribuire al benessere dei consociati e alla prosperità comune, e in tal modo libera il contesto dal suo passato oscuro, gli permette di fare chiarezza sulle proprie macchie e di aprirsi a nuovi scenari di partecipazione libera e democratica, senza i freni dell’omertà e della paura.
Nell’attività degli enti che gestiscono i beni confiscati alle mafie, il valore della trasparenza come presidio di legalità e come mezzo di attuazione dei diritti fondamentali dell’individuo si esprime nella sua forma più piena e più alta, manifestandosi su un duplice piano. Da un lato, la trasparenza, richiedendo che ogni informazione e ogni dato sia sottoposto all’attenzione dei cittadini, responsabilizza l’amministrazione stessa rispetto alle sue scelte, ne impone il rigore e l’efficienza e la indirizza verso il rispetto dei richiamati principi costituzionali di buon andamento e imparzialità. Dall’altro, nel fornire alla collettività un potente strumento di controllo diffuso, responsabilizza i cittadini stessi e li rende adulti e maturi, finalmente attori del bene comune e della gestione della cosa pubblica.
Al contempo, la trasparenza riduce il rischio di una cattiva amministrazione dei beni confiscati o, addirittura, di ulteriori infiltrazioni indebite nella fase di nuova destinazione degli stessi, consentendo di evitare che i patrimoni sottratti alla malavita finiscano di nuovo nelle mani o sotto il controllo della criminalità o non siano adeguatamente utilizzati per il perseguimento dell’interesse collettivo o, ancora, giacciano inutilizzati perché i cittadini non ne conoscono l’esistenza o non sanno che sono in vendita o allocabili per destinazioni economiche o per progetti di sviluppo.
Un eventuale silenzio degli enti pubblici sui beni confiscati alle mafie e sulle loro prospettive di recupero e utilizzo si tradurrebbe in un vero e proprio sfregio al desiderio di riscatto di una comunità, oltre che in un’ulteriore vittoria della malavita, ancora più subdola e odiosa, perché conseguita con la complicità delle stesse istituzioni.
Per tutte queste ragioni, quando è in gioco la destinazione di beni confiscati al malaffare, la violazione delle regole sulla trasparenza non si riduce mai solamente ad un mancato adempimento normativo, e nemmeno solo ad una perdita di valore economico dovuta al mancato utilizzo di un patrimonio, che pure potrebbe apportare un beneficio apprezzabile a enti spesso affetti da carenza di risorse. Vi è sicuramente di più. Risulta compromesso lo stesso valore civico e sociale che la condivisione delle informazioni, la trasparenza dell’azione amministrativa, la conoscenza dei beni sequestrati portano all’intera comunità. E, soprattutto, si perde il valore politico, rilevantissimo, della vittoria sul crimine e sulle mafie. Non basta aver sequestrato un bene alle organizzazioni criminali, se poi lo si nasconde e lo si sottrae alla collettività, come se ci si vergognasse di renderlo pubblico, o come se incombessero altri adempimenti più importanti cui dare seguito.
Nei confronti degli enti inadempienti, però, lo strumento del richiamo e della sanzione non è sufficiente. Occorre un’opera di sensibilizzazione e di responsabilizzazione, che porti tutte le amministrazioni a comprendere come gli adempimenti relativi alla trasparenza non sono oneri gravosi da posporre alla realizzazione di una strada o all’erogazione di un servizio, ma rappresentino la massima espressione della cura del bene comune, intesa come garanzia del diritto di informazione e di partecipazione.
In tale prospettiva, ANAC mette a disposizione degli enti, soprattutto quelli più piccoli e dotati di minori risorse, la propria struttura e i propri uffici e, attraverso l’istituto della vigilanza collaborativa, offre assistenza nell’applicazione della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.
Accanto a tale programma di sensibilizzazione rivolto a tutti gli enti, particolarmente a quelli chiamati a gestire i beni confiscati alla criminalità, occorre anche mettere in campo tutti gli strumenti offerti dalla digitalizzazione, assumendo l’innovazione tecnologica come potente alleato contro il crimine, in virtù delle sue enormi potenzialità in termini di prospettive di miglioramento dell’accesso al patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni sul duplice piano quantitativo e qualitativo.
In questo contesto si situa l’importante progetto della Piattaforma Unica della Trasparenza, che ANAC si è posta come obiettivo strategico: un punto di accesso unificato, gestito dalla stessa Autorità e basato sull’interconnessione con altre banche dati pubbliche, in grado di semplificare e rendere meno onerosa la pubblicazione dei dati, agevolando al contempo la fruibilità e, soprattutto, la confrontabilità degli stessi
attraverso l’adozione di un formato uniforme. La piattaforma, concepita come un luogo digitale in cui confluiranno le informazioni essenziali sull’attività di tutte le pubbliche amministrazioni, costituirà una sorta di finestra sull’agire delle PA, funzionale al controllo e alla partecipazione dei cittadini, i quali così potranno anche confrontare l’azione di diversi enti. Le stesse amministrazioni, inoltre, potranno trarre rilevanti vantaggi dal portale, sia perché saranno sollevate da diversi adempimenti di pubblicità, con risparmi economici e gestionali, sia perché potranno ricavare, anch’esse, beneficio dal reciproco confronto, nell’ottica della diffusione delle migliori pratiche, della creazione di nuove sinergie e di una più efficace collaborazione istituzionale.
La piattaforma, dunque, non sarà solo uno strumento per assicurare risparmi e semplificazioni, e neanche solo per accrescere la conoscibilità dell’agire pubblico, ma potrà proporsi e affermarsi come un vero volano di miglioramento gestionale e innovazione amministrativa.
Se rafforzata da specifici interventi normativi, essa potrà rivelarsi utile anche con riferimento ai beni confiscati alle mafie, favorendone la conoscibilità e assicurando la più ampia e agevole diffusione delle relative informazioni, come pure aiutando a individuare le amministrazioni inadempienti rispetto agli obblighi di pubblicità.
Le regole di trasparenza previste per gli enti assegnatari di beni confiscati alle mafie esemplificano, infatti, con la massima pregnanza la funzione che la trasparenza amministrativa svolge, come pilastro dell’ordinamento democratico e strumento di cittadinanza attiva e responsabile. Essere informati e consapevoli dell’attività della pubblica amministrazione, particolarmente quando questa operi in prima linea nel contrasto al crimine, rende protagonisti attivi della vita pubblica e sostenitori fiduciosi delle istituzioni.
Questo contributo è tratto dal volume tematico
Da beni mafiosi a beni comuni
Ferruccio De Bortoli