
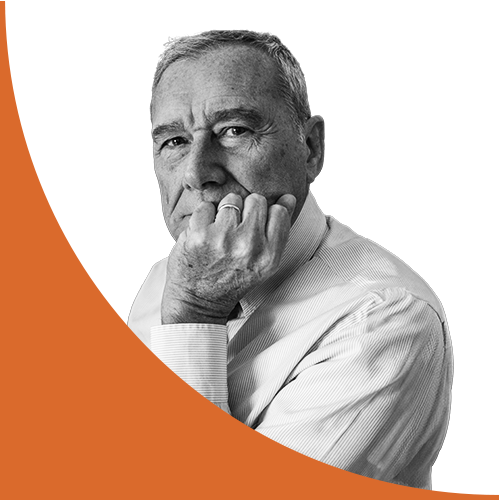
Presidente della Fondazione Scintille di Futuro
Condividi
La mafia è una storia di soldi
La storia della mafia, in ultima analisi, è una storia di soldi. Certo c’è il sangue, la violenza, la paura, il condizionamento della vita dei cittadini, ma tutto gira attorno alla ricerca della ricchezza attraverso le relazioni con le varie componenti del potere economico, finanziario, politico, sociale, da cui trarre le indicazioni per gli affari più vantaggiosi. L’economia criminale è protesa verso la conquista illegale di spazi di potere economico e inquina il tessuto produttivo e gli assetti istituzionali dei paesi in cui opera.
Il denaro delle mafie, corre veloce, cambia posto di continuo e, quando si materializza, la sua origine illecita è irriconoscibile, ricompare in circolo come linfa buona per nuovi affari. Ricostruire le decine di transazioni, rintracciarlo prima di finire negli scambi occulti, o negli acquisti, cessioni e vendite simulate, è la sfida del nuovo millennio.
Giovanni Falcone, già alla fine degli anni ’70 del secolo scorso, fu tra i primi ad approfondire questo nuovo aspetto ed a cogliere l’importanza dell’indagine patrimoniale per un serio contrasto alla mafia. Per ricostruire i flussi di denaro tra società (vere e proprie scatole cinesi), tra affari leciti e illeciti, spulciava ogni contratto, ogni rapporto di cambio, ogni assegno. Abbatté il simulacro di un segreto bancario, peraltro non opponibile al giudice; entrò nei forzieri delle banche, allora a completo ed omertoso servizio dei mafiosi; registrò legami, rapporti e relazioni, che avrebbero in seguito fornito adeguati riscontri alla composizione delle famiglie mafiose e della struttura piramidale di Cosa Nostra, rivelata dalle dichiarazioni dei più importanti collaboratori di giustizia.
Noi tutti abbiamo imparato tantissimo da quel suo approccio così innovativo.
Maxiprocesso: prima applicazione della legge Rognoni-La Torre
La legge del 1982 fu una svolta rivoluzionaria perché per la prima volta introdusse il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso e spalancò la porta alle indagini patrimoniali per arrivare al sequestro e alla confisca dei possedimenti mafiosi, non solo a seguito di condanna, ma anche a seguito di un processo di prevenzione nei confronti degli indiziati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, che non riuscissero a dimostrare la legittima provenienza del loro patrimonio (anche se intestato a prestanome) e sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica svolta. Con questo formidabile strumento legislativo, alla sua prima applicazione, per colpire i mafiosi sul piano personale e su quello patrimoniale, Falcone, utilizzando il suo efficace metodo investigativo, poté impostare una istruttoria, prima, ed un giudizio, poi, come il Maxiprocesso di Palermo, con 475 imputati di 438 delitti di mafia, tra cui 120 omicidi, che si concluse con 19 ergastoli, 2665 anni di reclusione, oltre 11 milioni e mezzo di multa e numerose confische di beni nei confronti di 346 condannati, di cui si accertarono anche le relazioni esterne con le realtà imprenditoriali e politiche, rappresentate dei cugini Salvo e da Ciancimino, cioè con quell’area che riusciva a far realizzare investimenti produttivi e grandi profitti, a persone che allora non avevano la competenza e la professionalià per farlo.
La destinazione sociale: un grande valore simbolico
“Vogliamo che lo Stato sequestri e confischi tutti i beni di provenienza illecita e che tali beni siano rapidamente conferiti, attraverso lo Stato e i Comuni, alla collettività per creare lavoro, scuole, servizi, sicurezza e lotta al disagio”: era questo l’incipit dell’appello con cui Libera promuoveva in tutta Italia la proposta di iniziativa popolare sottoscritta da oltre un milione di cittadini. Venne cosi approvata la Legge 109/1996 che introdusse il riutilizzo sociale dei beni confiscati ai mafiosi, come concreta alternativa all’utilizzo da parte delle istituzioni per le normali finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile. Il concetto del riutilizzo a fini sociali, oltre che una prospettiva di ordine economico, serviva a dimostrare che le ricchezze accumulate in danno dei cittadini alla fine, grazie all’azione dello Stato, tornavano alla collettività e si trasformavano in progetti di sviluppo nella legalità, in occasioni di riscatto dal giogo mafioso. Quando mi ritrovai, agli inizi del terzo millennio, alla guida della Procura di Palermo, mettendo a frutto le precedenti esperienze, mi resi conto sul campo che l’aggressione ai patrimoni mafiosi costituiva il più efficace mezzo di contrasto; significava colpire non solo uno dei punti di forza dell’organizzazione, ma anche una delle sue stesse ragioni di esistere.
Nei primi anni dopo l’introduzione della Legge Rognoni-La Torre, fino all’inizio degli anni ’90, i patrimoni mafiosi erano costituiti principalmente da case, terreni o attività imprenditoriali intestate agli appartenenti a Cosa Nostra o ai loro più stretti familiari, cosicché fu relativamente facile individuarli e poi confiscarli. Da allora, però le organizzazioni mafiose erano corse ai ripari: diversificando le modalità di investimento delle ricchezze illecitamente accumulate non più attraverso immobili ma con altre forme suggerite da esperti per renderle più difficilmente individuabili soprattutto nei paradisi bancari e fiscali e in fondi esteri. E invero, di fronte al livello di segretezza raggiunto dalle organizzazioni mafiose, si rese necessaria l’utilizzazione, anche per le misure di prevenzione, delle tecniche di indagine del procedimento penale e cioè le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le intercettazioni telefoniche e ambientali. Tali strumenti consentirono di raggiungere in poco tempo risultati estremamente positivi. Si pensi, ad esempio, al caso in cui dalle intercettazioni ambientali risultavano i prestanome o che una società si aggiudicava un appalto o una fornitura dopo avere estromesso con l’intimidazione i potenziali concorrenti ovvero le modalità di investimento dei profitti di un importante traffico di stupefacenti.
Soltanto l’avvio di una nuova stagione d’impegno collettivo, successiva alle stragi del 1992, consentì la piena realizzazione della strategia di aggredire i patrimoni mafiosi. Nel periodo 1993/2004 furono sequestrati beni per un valore di circa 12.000 miliardi di lire (circa 6,2 miliardi di Euro). Nel solo periodo 1.7.2002-30.6.2003 furono sequestrati beni per un valore di circa 1492 miliardi di lire (pari a circa 772 milioni di Euro). Nel periodo 1.1.2000-30.06.2004 furono avanzate ben 287 proposte di carattere patrimoniale, con un aumento di quasi il 500% rispetto al triennio 1996/1998.
Ricordo l’esperienza drammatica vissuta in quegli anni da Procuratore di Palermo, quando ricevevo quasi giornalmente amministratori giudiziari, i quali, seppur nominati e gestiti dai Tribunali per le misure di prevenzione, mi chiedevano di far da tramite con i carabinieri o con la Guardia di finanza per tutti i problemi creati sul territorio dalla presenza mafiosa.
Portai con me quell’esperienza nel mio successivo incarico di Procuratore Nazionale Antimafia, in quel ruolo dedicai moltissime energie a ideare una strategia capace di adattarsi al dinamismo e alla ricerca di invisibilità delle mafie, soprattutto in relazione alla loro capacità di cambiare pelle.
Non mancai di esercitare il mio ruolo di pungolo positivo nei riguardi del governo e del legislatore, chiedendo che finalmente al Procuratore nazionale e distrettuale antimafia (istituzionalmente in possesso di tutte le informazioni acquisite dalle indagini antimafia) fosse attribuito il potere di proposta delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti degli indiziati di tutti i delitti di loro competenza, quindi ben oltre quelli della sola associazione mafiosa, prima di competenza delle procure ordinarie sparse sul territorio. Inoltre chiedevo di introdurre il principio di autonomia dell’azione di prevenzione reale, rompendo la accessorietà delle misure patrimoniali a quelle personali, senza le quali, in carenza della attualità della pericolosità o in caso di morte, i beni sequestrati venivano restituiti. Si trattava di tracciare una diversa linea di politica criminale. Tali rilevanti modifiche al sistema furono pienamente accolte dal d.l. n. 92/2008, conv. dalla legge n. 125/2008.
Successivamente sempre da Procuratore Nazionale antimafia lottai, insieme a Libera, perché la competenza esclusiva del Demanio passasse ad un unico soggetto che potesse farsi carico della gestione dei beni, dal sequestro all’assegnazione, e che attraverso i Prefetti potesse intervenire con controlli delle forze dell’ordine, in modo da liberare intanto i terreni dalla presenza mafiosa e far vedere sul territorio la presenza dello Stato.
Alla fine tale proposta riuscì ad essere approvata solo nel 2010, con la nascita dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).
Il d.lgs. n. 159/2011 c.d. Codice Antimafia procedette poi sostanzialmente a una utile opera di ricognizione della legislazione precedente, mantenendo la confisca di prevenzione disgiunta dalle misure personali e regolando i complessi temi dell’amministrazione giudiziaria, della tutela dei terzi e dei rapporti con le procedure fallimentari.
Problemi e soluzioni
Da sempre l’esigenza principale è la necessità di procedere a rapide destinazioni dei beni che possano evitare danneggiamenti mafiosi e abbandoni usuranti.
La vera difficoltà per le aziende sequestrate e confiscate, però, è dover pagare il costo dello stato di illegalità in cui sono nate: lavoratori in nero o sottopagati, immobili con destinazioni d’uso irregolari, investimenti di danaro illecito, evasione fiscale e così via. Subito dopo il sequestro, il passaggio alla legalità fa scoprire che si tratta di scatole vuote, utilizzate per finalità di riciclaggio, oppure che hanno perso ogni capacità di stare sul mercato, per l’innalzamento dei costi di gestione, per la revoca dei fidi concessi dalle banche oppure per il deterioramento dei rapporti con la clientela e con i fornitori. È chiaro che l’unico destino ipotizzabile per queste aziende resta il fallimento e la consequenziale chiusura.
In realtà la soluzione sarebbe trovare, già al momento del sequestro e dell’immediata assegnazione, un adeguato sostegno economico e finanziario e implementare gli strumenti finanziari per la gestione dei beni e la valorizzazione delle imprese (ex articolo 41 del Codice Antimafia), soprattutto in considerazione della dimensione delle aziende, nella gran parte piccole e medie, che hanno difficoltà ad ottenere le linee di credito. Uno strumento utile potrebbe essere quello di applicare le procedure di co-programmazione e co-progettazione (ex articolo 55 del Codice del Terzo Settore) alla fase di assegnazione dei beni confiscati dal momento della loro destinazione agli enti locali.
Ad oggi, oltre alle risorse finanziarie di fondazioni ed enti privati, esistono le Politiche di Coesione e i Fondi Europei.
Purtroppo l’utilizzo di queste risorse è ancora sottovalutato e parzialmente disatteso sia nell’attuale ciclo di intervento europeo, sia nell’odierna fase di definizione della programmazione europea 2021/2027, sia infine alla luce del Piano nazionale di ripresa e resilienza, su cui si riponevano tante speranze, deluse dall’attuale Governo, che ha scelto di tagliare centinaia di progetti, per un totale di 300 milioni di euro.
In questo momento, come in ogni Legislatura, è stata depositata una proposta di Legge, che cerca di limitare la possibilità di sequestro e confisca. Dovremo vigilare che non proceda, perché sarebbe del tutto illogico e immorale fare passi indietro.
L’assalto non è ancora partito ma le mafie sono già lì in agguato, pronte a tuffarsi in quel fiume di denaro che arriverà con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tutti avvertono il rischio dell’aggressione ma oggi devono misurarsi con mafie sempre più invisibili. Il “sistema antimafia” sarà davvero in grado di respingere quell’assalto? Si sta dotando di leggi e strumenti più adeguati per fronteggiare le grandi holding del malaffare, nei settori della finanza, dell’energia, degli appalti pubblici e dell’interscambio di beni e servizi? O ritenendo valido il solo principio di responsabilità anziché anche quello di pericolosità, sta attuando il ricorrente disegno di eliminare dal nostro ordinamento le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, strumento indispensabile per contrastare un fenomeno complesso come la criminalità organizzata, che non si può affrontare soltanto con le misure ordinarie di repressione?
Questo contributo è tratto dal volume tematico
Da beni mafiosi a beni comuni
Ferruccio De Bortoli